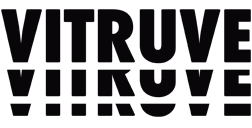19 de Agosto de 2025
Velocità media Vs Velocità media propulsiva. Differenze e applicazioni
L’efficacia dell’allenamento contro resistenza (RT) nel raggiungere obiettivi specifici dipende dalla corretta manipolazione di diverse variabili che influenzano in modo significativo sia le risposte acute sia le successive adattamenti fisiologici (Bird et al., 2005; Kraemer et al., 2002; Spiering et al., 2008). La prescrizione dell’allenamento deve considerare ciascuna variabile in base all’obiettivo prefissato, con l’intensità dell’esercizio come fattore chiave che influenza gli adattamenti neuromuscolari (Fry, 2004; Bird et al., 2005).
In questo contesto, l’allenamento basato sulla velocità (VBT) emerge come un metodo efficace per regolare con precisione l’intensità dell’allenamento quotidianamente. Questo approccio ha le sue radici nello studio pionieristico di González-Badillo e Sánchez-Medina (2010), che ha stabilito una relazione tra la percentuale di carico relativo (%1RM) nella panca piana e la velocità media propulsiva (MPV), dimostrando un valore di R² di 0,98. Questa scoperta permette alla velocità di sollevamento di fungere da indicatore dell’intensità relativa, eliminando così la necessità di test di 1RM o xRM. Studi successivi hanno esplorato questa relazione in vari esercizi, inclusi squat completi (Sánchez-Medina et al., 2017), trazioni prone (Sánchez-Moreno et al., 2017), e hanno anche identificato differenze tra i sessi per migliorare il controllo e l’individualizzazione (Pareja-Blanco, Walker, et al., 2020). Pertanto, misurando la MPV si può determinare automaticamente il %1RM.
Tuttavia, altri studi suggeriscono che misurare questa relazione utilizzando la velocità media (MV) fornisce una maggiore precisione per le equazioni di regressione generali che predicono il carico relativo (%1RM) a partire dalla velocità di movimento rispetto alla MPV (García-Ramos et al., 2018). Questo argomento ha generato un notevole dibattito sia nella comunità scientifica sia in quella professionale. A questo proposito, il testo che segue affronterà la questione e stimolerà una riflessione su quale variabile sia più appropriata per quantificare l’intensità in diverse situazioni e contesti.

Importanza della Fase Propulsiva
Per determinare quale velocità debba essere utilizzata per prevedere il carico relativo (%1RM) o per rilevare cambiamenti nella performance dovuti a un aumento della velocità di esecuzione contro qualsiasi carico assoluto, dobbiamo prima esaminare lo studio di Sánchez-Medina et al. (2010).
I risultati dello studio indicano che riferirsi esclusivamente ai valori di velocità media della fase propulsiva (MPV) quando si valuta la velocità e la potenza con cui un carico viene sollevato durante un’azione concentrica evita di sottostimare la capacità neuromuscolare di un individuo, in particolare quando si sollevano carichi leggeri e moderati. In questo senso, la fase propulsiva è definita come la porzione della fase concentrica durante la quale l’accelerazione (a) supera l’accelerazione gravitazionale (cioè, a ≥ -9,81 m∙s⁻²).
Per comprendere queste conclusioni in modo più chiaro e pratico, osserviamo le seguenti figure:
Figura 1. Fase concentrica di una ripetizione con il 20% di 1RM nell’esercizio di panca piana
Adapted from Sanchez-Medina et al. (2010)
Figura 2. Fase concentrica di una ripetizione con 20 kg (15,7% di 1RM) nell’esercizio di panca piana
Adapted from Sanchez-Medina et al. (2010)
Per prima cosa, è essenziale distinguere tra fase di accelerazione, fase di decelerazione, fase propulsiva e fase di frenata durante una ripetizione concentrica di un esercizio specifico, in questo caso la panca piana, come utilizzato nello studio di Sánchez-Medina et al. (2010). In questo esercizio, il movimento inizia da una velocità pari a zero quando il bilanciere è appoggiato sul petto, poi raggiunge una velocità massima durante la parte concentrica e ritorna a zero quando i gomiti sono completamente estesi e il bilanciere è fermo, indicando che la fase concentrica di quella ripetizione è stata completata. Questo comportamento della velocità può essere illustrato nelle Figure 1A e 1B al 20% di 1RM (punti tratteggiati) e nella Figura 2 al 15,7% di 1RM durante la panca piana (linea blu).
Un aspetto critico quando si sollevano carichi in esercizi isoinerziali tipici alla massima velocità intenzionale è che una parte significativa della fase concentrica viene spesa per decelerare la resistenza in movimento. Per osservare questo, dobbiamo prima capire che la forza (F) si calcola come F = m · (a + g), dove m è la massa in movimento (kg) e g è l’accelerazione di gravità. La produzione di potenza è il prodotto della forza verticale applicata e della velocità del bilanciere (P = F · v). In questo senso, possiamo osservare una fase di accelerazione che rappresenta il 70% della fase concentrica al 20% di 1RM (Figura 1B). Questa fase di accelerazione si riferisce alla porzione della fase concentrica in cui l’accelerazione è superiore a 0 m∙s⁻². Ciò indica la fase in cui la forza applicata è maggiore del peso sollevato (a favore del movimento). Questa fase continua fino a quando non si raggiunge la velocità massima. Al contrario, la fase di decelerazione rappresenta il 30% della fase concentrica al 20% di 1RM (Figura 1B), e si riferisce alla porzione in cui l’accelerazione è inferiore a 0 m∙s⁻². Ciò significa che la forza applicata è uguale o inferiore al peso sollevato (contro il movimento).
Considerando che la fase di accelerazione dura fino al raggiungimento della velocità massima, possiamo osservare nelle Figure 1A, 1B e 2 che anche in questo punto di velocità massima vi è ancora potenza (Figure 1A e 1B) e applicazione di forza (Figura 2), indicando che i valori di forza, e di conseguenza di potenza, rimangono maggiori di 0. Questo implica che la fase propulsiva dura leggermente più a lungo della fase di accelerazione, poiché viene definita come la porzione della fase concentrica in cui l’accelerazione è superiore a -9,81 m∙s⁻² (accelerazione di gravità). Pertanto, la fase propulsiva comprenderebbe la fase di accelerazione, dove si applica più forza di quanto rappresenti il carico, e la porzione in cui l’accelerazione passa da 0 a meno di -9,81 m∙s⁻², che corrisponde alla fase in cui la forza è uguale al peso sollevato. Così, mentre la fase di accelerazione in Figura 1B rappresenta il 70%, la fase propulsiva sarebbe del 76,7% (Figura 1A). La percentuale restante corrisponde alla fase di frenata, durante la quale l’accelerazione è inferiore a -9,81 m∙s⁻², e quindi l’applicazione della forza si oppone al movimento, anche se il bilanciere continua a muoversi fino al completamento della ripetizione (Figura 2). Questo movimento avviene inconsciamente per evitare che il bilanciere venga lanciato.
In sintesi, se otteniamo la VM (velocità media) di una ripetizione di panca piana, la velocità sarebbe la media di tutti i valori di velocità durante l’esecuzione. Tuttavia, la VMP (velocità media propulsiva) sarebbe la media di tutti i valori di velocità dall’inizio alla fine della fase propulsiva.
Differenze tra velocità media e velocità media propulsiva
Una volta comprese la fase di accelerazione, la fase di decelerazione, la fase propulsiva e la fase di frenata, possiamo esaminare come queste fasi influenzano un’azione concentrica sotto diversi carichi.
In questo contesto, è stato dimostrato che la fase di frenata è maggiore quando il carico è più leggero. Questo perché i carichi leggeri consentono di raggiungere velocità più elevate, che a loro volta portano a una fase di frenata più marcata (Figura 3).
Figura 3. Contributo relativo delle fasi propulsiva e di frenata alla durata totale della fase concentrica nell’esercizio di panca piana
Adapted from Sanchez-Medina et al. (2010)
Come esempio pratico, possiamo fare riferimento alla Figura 4, che mostra due fasi concentriche: una con un carico leggero (20% 1RM) e un’altra con un carico elevato (80% 1RM). In questa figura, possiamo osservare che la Potenza Media (PM) per il carico del 20% 1RM è stata di 256 W, mentre la Potenza Media Propulsiva (PMP) è stata di 422 W. Ciò indica che la PM durante l’intera fase concentrica è stata inferiore del 40% rispetto alla PMP relativa solo alla fase propulsiva.
Figura 4. Fase concentrica di una ripetizione con il 20% 1RM e una con l’80% 1RM nell’esercizio di panca piana.
Adapted from Sanchez-Medina et al. (2010)
Al contrario, queste differenze tra PM e PMP non esistevano quando il carico era all’80% 1RM, dove entrambi i valori erano di 318 W. Questo suggerisce che la disparità tra questi parametri diminuisce gradualmente man mano che i carichi sollevati diventano più pesanti, fino a raggiungere un punto in cui la fase di frenata scompare e i due parametri convergono.
In particolare, nell’esercizio di panca piana, è stato osservato che il carico al quale la fase di frenata cessava di esistere era del 76,1 ± 7,4% 1RM, e la velocità alla quale la fase di frenata non esisteva più era di 0,53 ± 0,07 m∙s⁻¹ (Figura 5).
Figura 5. Relazione tra il contributo della fase propulsiva alla durata concentrica totale del sollevamento e il carico (%1RM) (A); e la velocità media propulsiva e il contributo della fase propulsiva (B) nell’esercizio di panca piana.
Adapted from Sanchez-Medina et al. (2010)
In sintesi, secondo lo studio di Sanchez-Medina (2010), quando si sollevano carichi leggeri e moderati esiste una fase finale durante la quale la decelerazione è di maggiore entità rispetto a quanto ci si aspetterebbe esclusivamente per effetto della gravità. Ciò è dovuto al fatto che l’atleta applica forza nella direzione opposta al movimento del carico.
Applicazioni della velocità media e della velocità media propulsiva
Chiarita la definizione, esaminiamo ora un esempio pratico di come la scelta della velocità possa influenzare l’osservazione dei cambiamenti di prestazione in un esercizio specifico.
Nella Figura 6, possiamo osservare un test incrementale reale con carichi progressivi nell’esercizio di squat, che fornisce informazioni sui cambiamenti di prestazione con carichi bassi, moderati e alti.
Figura 6. Cambiamenti nella prestazione dello squat (VMP e VM) dopo un programma di allenamento di resistenza.
Dalle linee continue in questa immagine, possiamo concludere che l’atleta è migliorato, poiché è in grado di sollevare ogni carico a una velocità maggiore (da 20 a 100 kg con incrementi di 10 kg).
Inoltre, possiamo distinguere tra VMP e VM (linea continua vs. linea tratteggiata). Quando i carichi sono elevati, le velocità sono abbastanza simili; tuttavia, con carichi più leggeri emergono maggiori differenze tra VMP e VM. Questa osservazione supporta la discussione affrontata precedentemente riguardo alla fase propulsiva con carichi differenti.
È importante notare che la figura evidenzia come i cambiamenti di prestazione pre e post allenamento siano più marcati quando si confronta la VMP rispetto alla VM. Inoltre, se osserviamo il carico di 70 kg, vediamo che nel pre-test le differenze tra VMP e VM erano minime, mentre nel post-test questa differenza aumenta. Ciò accade perché, nel pre-test, il carico non era abbastanza basso da consentire un movimento ad alta velocità e una fase di frenata più lunga. Al contrario, nel post-test, l’atleta è migliorato e il carico assoluto di 70 kg rappresenta un’intensità relativa inferiore, permettendo una maggiore velocità di movimento e la presenza di una fase di frenata.
In sintesi, l’uso della VM fornisce una minore sensibilità rispetto alla VMP nel rilevare i cambiamenti di prestazione. Pertanto, se voglio comprendere davvero i miglioramenti del mio atleta, soprattutto con carichi leggeri, devo optare per la misurazione della VMP. Al contrario, la VM rimane un’opzione valida quando si osservano cambiamenti con carichi più alti (dove non esiste fase di frenata) o quando non si dispone di un dispositivo per misurare la VMP.
RIFERIMENTI
Bird, S. P., Tarpenning, K. M., & Marino, F. E. (2005). Designing resistance training programmes to enhance muscular fitness: a review of the acute program variables. Sports Med, 35(10), 841-851.
Fry, A. C. (2004). The role of resistance exercise intensity on muscle fibre adaptations. Sports Med, 34(10), 663-679.
García-Ramos A, Pestaña-Melero FL, Pérez-Castilla A, Rojas FJ, Gregory Haff G. Mean Velocity vs. Mean Propulsive Velocity vs. Peak Velocity: Which Variable Determines Bench Press Relative Load With Higher Reliability? J Strength Cond Res. 2018 May;32(5):1273-1279.
Gonzalez-Badillo, J. J., & Sanchez-Medina, L. (2010). Movement velocity as a measure of loading intensity in resistance training. Int J Sports Med, 31(5), 347-352.
Kraemer, W. J., Ratamess, N. A., & French, D. N. (2002). Resistance training for health and performance. Curr Sports Med Rep, 1(3), 165-171.
Martinez-Cava, A., Moran-Navarro, R., Sanchez-Medina, L., Gonzalez-Badillo, J. J., & Pallares, J. G. (2019). Velocity- and power-load relationships in the half, parallel and full back squat. J Sports Sci, 37(10), 1088-1096.
Pareja-Blanco, F., Walker, S., & Häkkinen, K. (2020d). Validity of using velocity to estimate intensity in resistance exercises in men and women. Int J Sports Med , 41(14), 1047-1055.
Rodriguez-Rosell, D., Yanez-Garcia, J. M., Sanchez-Medina, L., Mora-Custodio, R., & Gonzalez-Badillo, J. J. (2020). Relationship Between Velocity Loss and Repetitions in Reserve in the Bench Press and Back Squat Exercises. J Strength Cond Res, 34(9), 2537-2547.
Sanchez-Medina, L., Perez, C. E., & Gonzalez-Badillo, J. J. (2010). Importance of the propulsive phase in strength assessment. Int J Sports Med, 31(2), 123-129.
Sanchez-Medina, L., Pallares, J. G., Perez, C. E., Moran-Navarro, R., & Gonzalez-Badillo, J. J. (2017). Estimation of Relative Load From Bar Velocity in the Full Back Squat Exercise. Sports Med Int Open, 1(2), E80-E88. https://doi.org/10.1055/s-0043-102933 (Estimation of Relative Load From Bar Velocity in the Full Back Squat Exercise.)
Sanchez-Moreno, M., Rodriguez-Rosell, D., Pareja-Blanco, F., Mora-Custodio, R., & Gonzalez-Badillo, J. J. (2017). Movement Velocity as Indicator of Relative Intensity and Level of Effort Attained During the Set in Pull-Up Exercise. Int J Sports Physiol Perform, 12(10), 1378-1384. https://doi.org/10.1123/ijspp.2016-0791 Spiering, B. A., Kraemer, W. J., Anderson, J. M., Armstrong, L. E., Nindl, B. C., Volek, J. S., & Maresh, C. M. (2008). Resistance exercise biology: manipulation of resistance exercise programme variables determines the responses of cellular and molecular signaling pathways. Sports Med, 38(7), 527-540.